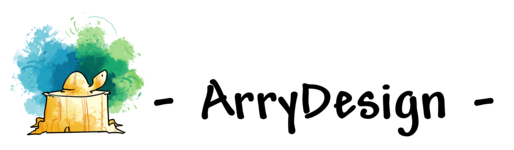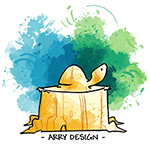Le loose parts sono quei materiali che possono essere utilizzati dai bambini (e dagli adulti) senza una funzione o uno scopo prestabilito. Uno degli aspetti fondamentali è che consentono ai bambini di scoprire, testare ipotesi ed esplorare il mondo in modo autonomo, seguendo i propri interessi, capacità cognitive e competenze. In questo modo, il processo […]